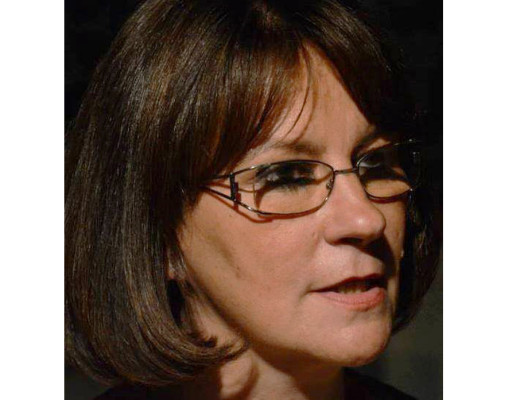Milton Fernàndez e Sabrina Camera nella commedia “Artemide” di Paolo Pietroni, per la regia di Elisabetta Vicenzi. “Artemide” è in scena il 17, 19, 20 dicembre 2015 al Teatro La Scala della Vita (via Piolti de Bianchi 47, Milano, ore 21). Foto di Alessandro Pozzi.
LUI, Milton Fernàndez. Appena lo guardi – è alto, ha le spalle larghe, i baffi e un accenno di barba – e lo senti parlare, capisci subito che è un uomo dall’inconfondibile fascino latino, artista alla ricerca costante della felicità (incrociata più volte, lasciata, poi ritrovata… d’altronde, “questo è il tango, bellezza”, ci si prende, ci si lascia, ci si ritrova nuovamente). Inutile dire che la calvizie non sa neanche che cosa significhi. E non certo perché lui, uruguaiano (è nato a Minas, a un centinaio di chilometri a nord-est della capitale Montevideo), non sappia l’italiano: lo parla quasi perfettamente – vive a Milano da 30 anni – con un accento leggero, inevitabilmente sensuale. Tanto per la cronaca, Milton è “libero di stato”, ma non ci è dato sapere se in questo momento sia innamorato, se sia stato mai sposato, né tantomeno se abbia un figlio (anche se, dopo aver visto una delle scene finali di “Artemide”, è difficile credere che non sia un padre). Ma questi sono solo dettagli di poco conto… quando si ha a che fare con un attore, regista teatrale, sceneggiatore, coreografo e scrittore che ha trascorso (e trascorre ancora) gran parte del tempo a cercare di cambiare il mondo.
LEI, Sabrina Camera. Non è di molte parole, anzi le misura come farebbe una poetessa (non è un caso che, insieme a Milton, abbia realizzato progetti come “La Vita Facile”, ispirato alla vita di Alda Merini, e “Guitarra Negra”, tratto da un poema cantato del cantautore uruguaiano Alfredo Zitarrosa). Quando balla, però, è come se raccontasse una storia infinita, fatta di mille emozioni e sfumature di stati d’animo. D’altronde – lo ha detto anche l’attore, regista e critico teatrale russo Aleksander Jakovlevič Tairov – “la danza comincia ove la parola si arresta”. I suoi movimenti sono un delicato equilibrio tra inquietudine, armonia e passione. Se non fosse bella, sul palcoscenico lo diventerebbe. Ma è una bella donna, oltre che una ballerina di talento che ha girato il mondo e lavorato con grandi nomi come Giorgio Strehler. È libera, dice, con un figlio di 8 anni che è l’uomo della sua vita.
Milton, ti ricordi il primo tango che hai ballato?
La mia prima volta è stata in una delle riunioni di famiglia, quando ero bambino. C’è una tradizione della cultura spagnola che si chiama la “sobremesa”: “mesa” è il tavolo, “sobremesa” è lo stare a tavola dopo pranzo fino alle 5, alle 6 del pomeriggio. Ecco, la domenica ci si trovava tutti a casa di mia nonna e a un certo punto, dopo aver finito di mangiare, qualcuno metteva la musica e si ballava. Si ballava il tango. Come si balla da noi, con le signore, le mamme, le zie. Quel tango molto “piccolo”, molto intimo. Da noi si dice che un bravo ballerino è capace di ballare sopra una piastrella, perché il tango si danza in un cerchio. Il tango, quello vero, che si può ballare in una milonga dove lo spazio è ristretto, è una cosa molto più intima di ciò che siamo abituati a vedere e a immaginare. L’atmosfera era bellissima. C’erano i miei zii che non avevano fatto scuola, né preso lezioni, avevano imparato tutti così, guardando. C’era anche chi faceva ridere, facendo passetti corti in punta di piedi. E c’era mia zia che mi diceva sempre: “Dai, adesso vieni a ballare tu!”. E io andavo a ballare la cumparsita.
La “cumparsita”?
Il tango più famoso qual è? La cumparsita! E la cumparsita è il tango uruguaiano. Sai, tra uruguaiani e argentini c’è da anni un’aspra rivendicazione circa la paternità del tango…
E che differenza c’è tra la cumparsita uruguaiana e il tango argentino?
Non c’è nessuna differenza, se non in qualche piccolissimo dettaglio. Il tango è una musica nata con gli immigrati, che arrivavano al porto di Buenos Aires e a quello di Montevideo. La chitarra spagnola si mischiò con i tamburi dei neri – ancora oggi nei quartieri neri di Montevideo si balla su note meravigliose – e con il “bandoneon”, l’organetto portatile che arrivava dalla Germania e che era stato “inventato” per accompagnare i funerali. Così nacque la musica del tango che, dai bordelli e dalle periferie poi, piano piano, guadagnò l’ingresso al centro. Tra mille scandali perché, ai tempi, ballare con i corpi che si toccavano non era permesso. Ricordo che c’erano dei cartelli che vietavano di ballare con il “corte y quebrada”, cioè facendo quei movimenti che rimandavano in senso erotico all’atto sessuale.
Torniamo a quella famosa domenica da tua nonna: qual è stata, quindi, la tua prima emozione legata al tango?
Ricordo che ero molto impacciato, però avevo tanta voglia di imparare. In realtà, per superare la goffaggine iniziale, basta recuperare il senso del ritmo, quel senso che abbiamo tutti fin dalla nascita e che spesso perdiamo. È il ritmo che ci collega alla terra, che ci fa scivolare con i piedi ma rimanere connessi con il centro. Una volta che questo ritmo viene recuperato, la questione è quella di sentire, sentire il corpo della donna e la musica, e di lasciarsi andare. Poi i passi del tango sono semplici: sono un cerchio.
Se anche tu all’inizio eri impacciato, ne deduco che non è facilissimo ballare il tango, neanche per chi lo ha nel sangue…
Noi sudamericani siamo avvantaggiati, perché abbiamo un diverso rapporto con il corpo. Gli uruguaiani, per esempio, quando si incontrano per la prima volta, sono abituati – tutti, uomini e donne – ad abbracciarsi e baciarsi. È una cosa che dipende da dove sei nato e cresciuto, dal sole, dalla temperatura, dal calore. Se lo fai qui a Milano, ti guardano un po’ male. Insomma, abbiamo una grande fisicità, a cui gli europei non sono soliti. Infatti quando andate a ballare in discoteca, tendete a muovere solo le braccia verso l’alto, mentre dai fianchi in giù il corpo è rigido come il bastone di una scopa. Ecco perché, durante le lezioni di teatro, il merengue è una tappa fissa del mio insegnamento: imparare a muovere il bacino è fondamentale per entrare in contatto con tutto il corpo.
Sabrina: Non saprei dire se sia solo di noi europei o di tutti, ma aggiungerei un’altra difficoltà con cui ho dovuto fare i conti durante la mia “prima volta”. Ero in Argentina e vivevo in famiglia con una ragazza che si chiamava Sole. Una sera lei mi ha portato in una milonga. Ero completamente a digiuno di qualsiasi tipo di informazione sul tango. Il difficile è stato abbandonarmi. Rinunciare al controllo sul corpo e sulla mia persona. Alla fine, però, mi sono buttata e mi sono anche divertita. È stata una bella emozione il lasciarsi andare, l’abbandonarsi all’altro.
Nel tango, quindi, la donna ha il compito di seguire, di abbandonarsi?
La donna che si consegna e si fa portare non è passiva. Dice: “Ok, vediamo se sei capace di portarmi”. E se l’uomo non lo è, lei lo può abbandonare in mezzo alla pista! Questo era uno dei più grandi motivi di vergogna del ballerino. Se, poi, la donna guardava un altro, i due uomini si andavano a sfidare fuori oppure uno cedeva il posto all’altro. Tutto questo mi ha fatto sempre ricordare il rituale d’accoppiamento delle aquile. Si abbracciano in aria e poi si lasciano cadere in picchiata. Se il maschio si risolleva, risale prima della femmina, allora vuol dire che è un fifone e che lei non lo sceglierà. È il gioco della femminilità sempre presente nella mitologia latinoamericana, dove la donna può essere passiva perché decide di esserlo, ma il maschio se la deve sempre guadagnare.
Se tu mangiassi una delle caramelle del personaggio che interpreti, il venditore di sogni di “Artemide”, quale sogno vorresti fare?
Il sogno in cui mi metto in gioco, faccio centinaia di cose che magari mi mettono paura, perché no, ma continuo imperterrito a mantenere lo spirito che mi ha animato finora. Perché poi arriverà un momento in cui si diventerà fragili, pieni di fobie. Nel mio sogno continuerei a provare e a trovare delle meraviglie, come questo gruppo di lavoro, come Sabrina che conosco da tanto tempo…
Sabrina: Da 18 anni, per la precisione, e forse più. Io, invece, vorrei sognare di essere continuamente in viaggio verso l’Argentina, per vivere il tango come lo vivono gli argentini, per respirarne l’aria nelle strade, nelle milonghe.
Qual è la scena di “Artemide” che ti è sembrata più difficile da interpretare?
Non ce n’è una specifica, sono tutte quante complesse, non sono piatte, hanno molte sfaccettature. La più divertente la più ricca di sensazioni forse è quella con la quale poi raccontiamo tutta l’allegoria dello spettacolo: si inizia con una provocazione, uno schiaffo, finiamo per fare l’amore, ci lasciamo, ci prendiamo e alla fine il corollario recita: “È il tango, bellezza!”.
Riprendendo il fil rouge che attraversa le scene dello spettacolo, dimmi, di che colore è la luna questa sera?
Per me è grigia, il grigio della scighera di Milano, della nebbia che considero fantastica, una delle cose che mi hanno fatto innamorare di questa città. L’ho maledetta tante volte ma, quando non c’è, mi manca. Rappresenta ciò che ho trovato qui, le persone che ci abitano, impenetrabili solo all’inizio, gli affetti, la mia seconda casa, le radici che non avevo. Ho viaggiato per lavoro, ho provato a stabilirmi in altre città, a Roma per esempio, ma poi sono sempre tornato a Milano. Dove ho portato il modo di vivere di un sudamericano, per il quale, per esempio, la cultura è fatta da tutti. Ecco perché, tra le mille cose che faccio, seguo con passione come direttore artistico il Festival della Letteratura di Milano, dove gli eventi nascono qua e là in luoghi completamente inaspettati e con una grande partecipazione di tutti.
Un’ultima domanda, che serve (forse) a distruggere un cliché. Si dice che tango vuol dire gelosia. Sei geloso?
No. La gelosia nasce dalla necessità di possedere delle cose o delle persone. Non ho mai pensato di dover possedere un’altra persona. Ho creduto sempre che il vero amore sia poter dire: io voglio il bene di quella persona al di là di me, oltre il fatto che stia con me. Con i libri, invece, sono un po’ possessivo. Quando mi mancano, mamma mia, apriti cielo! Ma questa è l’unica cosa per cui nutro una forma di possesso.
Sabrina: Io, invece, non sono gelosa né delle cose, né degli affetti.
È forse un messaggio per qualcuno?
Chi lo sa? Accontentatevi di sapere che per me questa sera il colore della luna è rosso, come l’amore, perché in questo momento sono innamorata…
“Cambalache” cantato da Julio Sosa: è il tango con cui Milton Fernàndez sostiene di avere un rapporto particolare. Le parole esprimono il concetto che il mondo è diventato una porcheria, dove non è più possibile distinguere il bello dal brutto, gli onesti dai ladri, la ragione dalla pazzia. Tutto è accatastato senza senza un senso, come in un cambelache: il negozio di un rigattiere.
—————————- intervista e testo di Marianna Sax, 7 dicembre 2015 —————————-